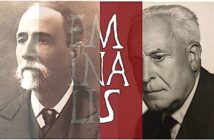ù
FEDERICO MUSSUTO
La Groenlandia negli ultimi mesi sta vivendo un momento storico sotto i riflettori internazionali, a seguito delle nuove affermazioni di Trump che, dal 2019 ad oggi, non sono cambiate ma divenute più insistenti sull’interesse a stelle strisce per l’isola. Ma la Groenlandia, chiamata terra verde dall’avventuriero vichingo Erik il Rosso per attirare i coloni, ha una storia di abitazione umana che risale a più di 4.000 anni fa. La regione autonoma della Danimarca è stata sede di popoli nativi che hanno attraversato l’Artico da quello che oggi è il Canada, coloni norvegesi, missionari luterani e personale militare statunitense che l’hanno usata come base da cui proteggere gli Stati Uniti dalla Germania nazista, che occupò la Danimarca nell’aprile 1940, e dall’Unione Sovietica. Ora un clima di riscaldamento e una rinnovata competizione per le risorse artiche promettono un boom economico per l’isola più grande del mondo, che ospita circa 56.000 persone, di cui quasi 20.000 solo nella capitale Nuuk, la maggior parte provenienti da background Inuit. I primi umani arrivarono nel nord della Groenlandia da quello che oggi è il Canada, dopo che lo stretto che separa l’isola dal Nord America si è congelato. Questa sarebbe stata la prima di sei ondate di immigrazione che hanno portato i popoli Inuit in Groenlandia, attorno al 2500 a.C. Con il passare del tempo, diversi storici e archeologi hanno rinvenuto armi e monete di epoca precedente a quella vichinga che servirebbero, in futuro, a riscrivere la storia, come attestato da diversi scritti del giornalista di Radio Rai, Elio Cadelo, che nella prefazione del libro “Quando i Romani andavano in America”, curata dall’astrofisico Giovanni Fabrizio Bignami, già Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, parla apertamente del Paradosso di Cristoforo Colombo :”L’importante, per avere il merito di una grande scoperta, è essere l’ultimo a farla, non il primo“. Nel 985 Erik Thorvaldsson, noto come Erik il Rosso, approdò sulle coste meridionali dell’isola, il quale, nato in Norvegia, dovette fuggire in Islanda a seguito di un omicidio, ma successivamente venne esiliato dalla nuova terra per medesimo reato. Dopo tre anni di esplorazioni, rientrato in Islanda iniziò a parlare ai pescatori e allevatori della presenza di una terra verde a nord, incentivando una spedizione di 25 navi, di cui nove andarono disperse nel tragitto e le restanti fondarono due comunità, una a Østerbygd e l’altra a Brattahlid, dove si stabilì Erik e a seguito della sua morte venne ribattezzata Eriksfjord. I norreni vissero per oltre cinque secoli in questa terra, portando il paganesimo nordico e il cristianesimo con Leif Erikson, secondogenito di Erik, poi divenuto noto come primo europeo a sbarcare in America, precisamente nel nord dell’isola di Terranova. La vita e l’operato di Leif divennero nei secoli successivi un cult, portando Lyndon Johnson nel 1964 a stabilire il 9 ottobre il Leif Erikson Day, per celebrare la prima venuta europea sul suolo americano, diventando, nel cartone animato di Spongebob, il giorno preferito dal protagonista. Un collante culturale tra America ed Europa importante come il Columbus Day, nato nel 1869 a San Francisco dalla comunità italo-americana e divenuta nel 1937, per volontà di F.D. Roosevelt, festa federale. Nel XIII secolo arrivarono i Thule, originari dell’Alaska, che man mano, nel nord dell’isola sostituirono gli originari abitanti, i Dorset, che dopo i cambiamenti climatici, avvenuti attorno all’anno Mille, videro diminuire gradualmente la loro popolazione. Questo periodo medievale andò a caratterizzare l’attuale popolazione groenlandese che è originaria per il 90% dai Thule che si diffusero nei secoli successivi anche a sud, verso l’attuale Nuuk, nel XVI secolo. Il 3 luglio 1721 raggiunse la Groenlandia il missionario luterano Hans Egede, il quale formatosi in Teologia presso l’università di Copenaghen, svolse attività pastorale nella contea norvegese di Nordland, ove apprese dei racconti sui vichinghi che si spostarono a nord-ovest. Così, nel maggio del medesimo anno della spedizione, Egede chiese al re di Danimarca, Federico IV, il permesso di cercare la colonia europea perduta e di convertire al cristianesimo i popoli del Nord. Nei primi mesi, il missionario cercò di stabilire dei contatti con i primi Inuit conosciuti, riuscendo a convertire al cristianesimo una parte della popolazione, decidendo di costruire una nuova realtà abitativa, fondando Godthåb, l’attuale Nuuk. Nel 1724 ci fu il primo battesimo in Groenlandia. A distanza di un decennio, il nuovo re di Danimarca, Cristiano VI, introdusse la stavnsbånd, che obbligava i contadini a risiedere nella loro regione nativa e che rendeva gli stessi contadini soggetti sia alla nobiltà locale sia all’esercito, richiamando in patria anche i pastori come Egede. Quest’ultimo si rifiutò e si stabilì con la moglie Gertrud fino alla morte di lei, avvenuta nel 1735, a causa del vaiolo. Nel 1741 Hans Egede divenne il primo vescovo della Groenlandia, fondando nel 1747 un catechismo sull’isola per dare continuità al sentiero cristiano. A seguito della sua morte, avvenuta nell’isola di Falster, in Danimarca, nel 1758, si ebbe anche il primo santo venerato vissuto in Groenlandia, commemorato ancora oggi nella città di Aasiaat. In epoca contemporanea venne dedicato il cratere lunare Egede, situato nella parte nord orientale della faccia visibile della Luna, sul confine meridionale del Mare Frigoris. Dopo un secolo e mezzo di predominio danese-norvegese in Groenlandia, nel 1814, a seguito della sconfitta delle guerre napoleoniche, si arrivò a siglare il Trattato di Kiel che vide la cessione della Norvegia al Regno di Svezia, divenendo così l’isola una colonia danese. Con l’avvento dell’era industriale, anche la Groenlandia ebbe una svolta significativa nella sua storia ottocentesca, poichè a Invittuut venne scoperto il più grande giacimento di criolite (oggi presente in Groenlandia, Colorado e Urali), minerale utilizzato nella produzione di alluminio. Hans Christian Ørsted, fisico e chimico danese, fu il primo a isolare in forma impura l’alluminio, sfruttando la reazione tra amalgama di potassio e cloruro di alluminio. Con i successivi studi e miglioramenti di Friedrich Wöhler e Henri Sainte-Claire Deville, nel 1886 ci fu la svolta per la diffusione industriale dell’alluminio grazie al processo di Hall-Héroult, cioè l’elettrolisi di allumina disciolta in criolite. In vista delle elezioni del marzo 2025, a Nuuk è stato distribuito un documentario dal titolo “L’oro bianco della Groenlandia”, che ripercorreva l’estrazione di criolite dal 1854 al 1987 a Invittuut, che avrebbe contribuito a portare nelle casse della corona danese e dell’industria addetta all’estrazione oltre 54 miliardi di euro, facendo breccia al cuore dei groenlandesi che dal 2009 cercano di tutelare la sovranità delle materie prime e dell’ambiente. Nel 1915, a un anno dallo scoppio della Prima guerra mondiale, gli Stati Uniti, ancora neutrali nel conflitto con il semplice supporto logistico-militare nei confronti degli alleati, attenzionarono il ruolo strategico delle isole del Mar dei Caraibi:Saint John, Saint Croix e Saint Thomas, oggi parte dell’arcipelago delle Isole Vergini Americane. Dal 1672, queste terre, possesso della Compagnia danese delle Indie Occidentali, sfruttate per due secoli per il commercio di armi dalla Danimarca verso l’Africa, mentre di zucchero, rum, melassa e schiavi nella rotta inversa. Con l’abolizione della schiavitù nel 1848, l’Ottocento fece perdere l’appeal di queste isole per la Corona, mentre per Washington, dal 2 dicembre 1823, era nata la Dottrina Monroe, l’idea della supremazia degli Stati Uniti nel continente americano, che avrebbe portato gli USA verso un approccio più spinto della politica estera. In pieno conflitto mondiale, Washington, essendo una potenza dei mari, temeva l’ascesa dei sommergibili e delle tecnologie belliche della marina tedesca, così iniziò a pensare a un piano di acquisto per le tre isole danesi dei Caraibi, che avrebbero dato una posizione privilegiata sulla tratta dei commerci tra Europa e il Canale di Panama, iniziato nel 1904 e poi inaugurato nel 1920. Washington propose un’offerta di 25 milioni di dollari al re Cristiano X. A seguito di un referendum, venne finalizzata la cessione nel 1917, celebrata nel migliore dei modi da Wilson solo alla fine del conflitto mondiale, assieme all’annessione di Porto Rico e il rafforzamento su Haiti e Cuba ma con il riconoscimento ufficiale da parte degli Stati Uniti della Groenlandia come terra di diritto della Danimarca. Il 22 luglio 1919 vi fu la Dichiarazione di Ihlen, rilasciata dal ministro degli Esteri norvegese, Mils Claus Ihlen, sul tema della sovranità della Danimarca sulla Groenlandia. Nel 1933 si arrivò a discutere alla Corte permanente di giustizia internazionale della questione orientale della Groenlandia, occupata dalla Norvegia dal periodo del Primo conflitto mondiale. Alla fine, la Corte di Giustizia Internazionale andò a risolvere la controversia dei territori con un trattato tra Norvegia e Danimarca.
Se, nel Primo conflitto mondiale, le preoccupazioni americane erano rivolte al Mar dei Caraibi, durante il Secondo conflitto Mondiale, dopo l’occupazione della Danimarca da parte dei nazisti, i governatori danesi della Groenlandia, Eske Brune e Axel Svane, dichiararono l’isola temporaneamente indipendente dalla Danimarca, per evitare ingerenze tedesche. In collaborazione con Henrik Kauffmann, ambasciatore danese a Washington, instaurarono un dialogo con gli Stati Uniti affinché assicurassero rifornimenti, fondamentali per la Groenlandia, che già al tempo era pesantemente dipendente dalle importazioni danesi, e protezione da possibili invasioni della Wehrmacht. Il 9 aprile 1941 venne così siglato “l’Accordo sulla difesa della Groenlandia”, con cui l’isola diventava un protettorato degli Stati Uniti. Washington otteneva il permesso di costruire alcune basi militari sul territorio, permesso che in origine doveva decadere al concludersi della minaccia tedesca, ma che fu poi prolungato. Nel corso della Seconda guerra mondiale, il ruolo strategico dell’isola divenne sempre più evidente, poichè l’assenza di tecnologie satellitari rendeva fondamentale l’installazione di stazioni meteorologiche in Groenlandia per pianificare le operazioni militari. Dalla base militare di Narsarsuaq, nel sud dell’isola, vennero ottenute previsioni fondamentali per la riuscita dello sbarco in Normandia del 6 giugno del 1944. Gli anni della guerra furono fondamentali per gli americani per incrementare la consapevolezza del ruolo che potesse giocare quell’isola nell’era post bellica, usando il fenomeno della cooperazione con la Danimarca come un cavallo di Troia per impossessarsi militarmente del territorio, in ottica antisovietica.
Finita la guerra e fattasi la pace, il presidente Truman, seguendo l’operato di Andrew Johnson che nel 1867 acquistò l’Alaska dalla Russia, propose un piano d’acquisto per l’isola più grande del mondo nel 1946 come contromossa al desiderio danese di porre fine al precedente accordo del 1941. L’idea venne presentata al governo danese quando il ministro degli Esteri Gustav Rasmussen arrivò a Washington a dicembre. Il suo equivalente statunitense James Byrnes presentò tre opzioni in quell’occasione:
- un accordo di base esteso che consentisse agli Stati Uniti di costruire varie basi militari e zone di difesa in Groenlandia con pieno controllo militare degli Stati Uniti e piena libertà di movimento all’interno di queste aree;
- un accordo di difesa che affidasse agli Stati Uniti il compito di difendere la Groenlandia (essenzialmente un modello di esternalizzazione);
- la vendita della Groenlandia agli Stati Uniti – l’opzione preferibile, come chiarito da Byrnes.
Secondo fonti statunitensi, Gustav Rasmussen rimase scosso dalla terza opzione, a tal punto da dire all’ambasciatore degli Stati Uniti in Danimarca: “Mentre dobbiamo molto all’America, non sento che dobbiamo dare a voi l’intera isola della Groenlandia”. Questa reazione assomigliava alla reazione pubblica del primo ministro danese Mette Frederiksen a seguito dell’offerta di Trump del 2019 bollata “una discussione assurda”.
Questo incidente diplomatico del 1946 è interessante per almeno due motivi: il desiderio americano di comprare l’isola e il rifiuto danese di vendere. Se consideriamo prima la prospettiva americana, è risaputo che l’acquisto di terreni non fosse una nuova opzione nella cassetta degli attrezzi politici degli Stati Uniti. Tuttavia, quando cercarono di organizzare un nuovo ordine internazionale dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti si posizionarono come campioni di un nuovo mondo postcoloniale, facendo pressione sugli stati europei per porre fine al dominio coloniale all’estero. C’era un timore diffuso nel governo danese che la rivendicazione degli Stati Uniti sulla Groenlandia avrebbe spinto l’Unione Sovietica ad aumentare la pressione sulla Danimarca in un momento in cui aveva appena lasciato l’isola baltica di Bornholm, dopo quasi un anno di occupazione. Senza la Groenlandia sarebbe stato più facile perseguire la tradizionale opzione di politica di sicurezza danese di guidare un corso che non si basasse sull’allineamento del blocco.
Le voci a Copenaghen suggerivano che il guadagno dalla vendita dell’isola sarebbe stato un miliardo di dollari, quasi quattro volte tanto quanto l’aiuto Marshall ai danesi. Sebbene queste voci possano aver sopravvalutato la generosità degli Stati Uniti, non c’è dubbio che una vendita avrebbe incanalato una somma sostanziale di dollari USA nel tesoro danese in un momento in cui quasi tutti i paesi europei, inclusa la Danimarca, erano disperati per colmare il crescente “divario in dollari” e soddisfare sia gli investitori che i consumatori nel mercato interno. Tuttavia, il governo non adescò. Nella sua risposta immediata all’offerta americana, il ministro degli Esteri danese, Gustav Rasmussen, nel dicembre 1946 confuse l’argomento degli Stati Uniti, secondo cui la Groenlandia non era una risorsa economica per la Danimarca, affermando che né il denaro né considerazioni economiche in senso più ampio determinavano il rapporto con la Groenlandia. In primo luogo, perché non volevano che la questione fosse politicizzata e internazionalizzata in quanto ciò avrebbe potuto presentare all’Unione Sovietica un pretesto per impegnarsi con ritorsioni; e, in secondo luogo, perché era diventato sempre più chiaro ai decisori che la sicurezza danese della Guerra Fredda, in ultima istanza, dipendeva dall’impegno e dalla capacità di difesa degli Stati Uniti. “Non mordere la mano che ti nutre” sembra essere stata la strategia messa in atto. Per un breve periodo, il governo di Hedtoft credette che l’adesione danese al Patto Atlantico potesse produrre una soluzione soddisfacente. Il suo appello riguardava una multilateralizzazione della difesa della Groenlandia all’interno della NATO che avrebbe ridotto la presenza degli Stati Uniti e impedito alla Danimarca di affrontare gli Stati Uniti da sola nelle discussioni bilaterali.
Allo stesso modo, questa speranza si rivelò vana, poiché questo non fu ciò che il governo degli Stati Uniti aveva avuto in mente. Gli Stati Uniti volevano mantenere il massimo del controllo nazionale sulla questione della Groenlandia e di conseguenza negoziare solo una soluzione bilaterale. Ciò si concretizzò con l’accordo per la difesa della Groenlandia nel 1951, sostituendo il precedente accordo del 1941. Il carattere di vasta portata dei diritti militari statunitensi nelle aree di difesa sono espressi nell’articolo II, sezione 3(b):
“Salvo la sovranità del Regno di Danimarca su tale area di difesa e il diritto naturale delle autorità danesi competenti alla libera circolazione ovunque in Groenlandia, il governo degli Stati Uniti d’America, senza compenso al governo del Regno di Danimarca, ha il diritto all’interno di tale area di difesa e degli spazi aerei e delle acque ad essa adiacenti: … di costruire, installare, mantenere e gestire strutture e attrezzature … e di immagazzinare forniture”.
Sulla base di tali libertà non c’è da meravigliarsi che un funzionario del Pentagono, in un rapporto al presidente Eisenhower, alla fine degli anni ’50, abbia osservato che il governo danese era stato “molto collaborativo nel consentire agli Stati Uniti una mano libera in Groenlandia”. In Groenlandia, c’era ovviamente una certa distanza tra realtà e finzione quando si trattava di determinare la sovranità. Nel 1953, la Terra verde smise di essere una colonia danese e divenne una contea della Danimarca, con un emendamento costituzionale. Il vero potere, tuttavia, rimase a Copenaghen, con il Ministero della Groenlandia. Nella primavera del medesimo anno, 116 persone, provenienti da 26 famiglie dovettero lasciare Uummannaq, nord-ovest dell’isola, su richiesta delle autorità. In quella realtà abbandonata, nacque la base militare americana di Thule, 233.000 acri, che diede inizio al programma militare americano nell’isola, assieme alle successive basi di Camp Century e Camp Fistclench. Sempre nel 1953, gli americani chiusero il Consolato a Nuuk, riaperto solamente il 10 giugno 2020, all’epoca un comune di 1600 anime, per aprire l’ambasciata a Copenaghen. In quel periodo, prese il via il Progetto Iceworm, piano top secret dell’esercito americano, divenuto di dominio pubblico solamente nel gennaio 1995, con documenti declassificati l’anno successivo, quando si avviò un’indagine sull’uso e lo stoccaggio di armi nucleari in Groenlandia condotta dall’istituto danese di politica estera (DUPI) su mandato del Parlamento, che la richiese a seguito dell’incidente che avvenne nel 1968, presso la base aerea Thule, un’enclave amministrativa americana, vicino al comune di Avannaata, dove rimase coinvolto un B-52 con a bordo ordigni nucleari. Nel 1957 la Danimarca aveva bandito le armi nucleari dall’intero territorio danese e nel 1958, il primo ministro danese Hans Christian Svane Hansen aveva sottolineato come la NATO dovesse astenersi dal prendere in considerazioni delle misure che avrebbero provocato e osteggiato la politica della distensione con Mosca. Tuttavia, quando l’ambasciatore statunitense Val Petersen scrisse ad Hansen per discutere la possibilità di stoccare armi nucleari in Groenlandia, il primo ministro rispose:
“Il governo statunitense ha il diritto di stoccare materiale, provvedere alla sicurezza dell’area, ecc… […] Tutti i materiali e rifornimenti saranno permessi nel territorio della Groenlandia senza alcuna ispezione. Non avete presentato alcun piano concreto riguardo ad un possibile stoccaggio, né avete posto domande sull’atteggiamento del governo danese a questo riguardo. Non penso che le sue osservazioni suscitino commenti da parte mia”.
Nel 1960, il Dipartimento della Difesa statunitense affermò che il progetto di Camp Century aveva come scopo quello di testare l’utilizzo di varie tecniche di costruzione in condizioni artiche e valutare i problemi pratici connessi all’utilizzo di un reattore nucleare mobile, con lo scopo finale di supportare la ricerca scientifica condotta sulla calotta glaciale. Le richieste ai groenlandesi di avere un maggiore controllo sui propri affari culminarono nell’Home Rule Act, che istituì il parlamento groenlandese, dando alle autorità locali il controllo su questioni come l’istruzione, la salute e la pesca. La legislazione fu approvata dal parlamento danese e ratificata dal 70% degli elettori locali. Nel 2004, l’accordo di difesa tra Stati Uniti e Danimarca venne aggiornato per fornire garanzie che la Groenlandia sarebbe stata inclusa nelle discussioni sulla politica militare statunitense nel Paese. Ma la Danimarca, che forniva più della metà del bilancio della Groenlandia, mantenne il controllo della sicurezza e della politica estera, come ribadito nel 2009 dal Autogovernment Act. Per Sara Olsvig, ex membro del parlamento danese e groenlandese e attuale presidente del Consiglio circumpolare Inuit – un’organizzazione no-profit internazionale che sostiene i diritti degli indigeni – gli obiettivi dell’America in Groenlandia sono evidenti: il suo esercito vuole mantenere l’accesso alle basi militari statunitensi e danesi esistenti (e possibilmente espanderle), mentre il suo governo vuole le ricchezze minerarie della Groenlandia. “C’è un chiaro interesse per gli Stati Uniti, che è condiviso da altri membri della NATO”, afferma Olsvig. “Che c’è un’isola enorme con molte risorse che è geopoliticamente in un luogo molto importante. E tutti intorno al tavolo lo sanno. Compresa la Groenlandia.”
Nel 1991, sul finire della Guerra Fredda e l’avvento del momento unipolare, si siglò l’Artic Environmental Protection Strategy che portò nel 1996, a seguito della Dichiarazione di Ottawa, alla formazione del Consiglio Artico, al fine di garantire alla regione uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. La sede del Consiglio Artico venne istituita a Tromsø, in Norvegia, con 8 membri: Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Stati Uniti e Svezia. Questo momento diede inizio alla nuova visione contemporanea dell’Artico e dunque della Groenlandia Contemporanea.