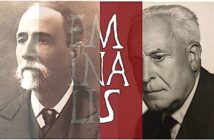FEDERICO MUSSUTO
Le tensioni tra Washington e Pechino non nascono sotto l’ultima presidenza repubblicana di Donald Trump ma sono solo l’ultimo capitolo di una sfida geopolitica nata in piena guerra fredda. I “Pentagon papers”, trapelati nel 1969, dimostrano come la decisione di bombardare il Vietnam del Nord e la seguente approvazione del Congresso per lo schieramento militare nell’Indocina siano stati voluti a sostegno di una politica estera di lungo corso per contenere la Cina. All’epoca, i giornali fecero emergere come vi erano, e ci sono ancora, tre fonti per uno sforzo a lungo termine per arginare la potenza comunista: il fronte Giappone-Corea, il fronte India-Pakistan e il fronte sud-est asiatico. Da allora, è chiaro che la presenza e alleanza statunitense sia in Giappone che in Corea del Sud, la successiva campagna ventennale d’Afghanistan, la vicinanza d’intelligence tra Langley e Islamabad siano da individuare come scacchiera strategica per mettere un freno a qualsiasi movimento di Pechino. Sempre in quest’ottica si colloca la nascita nell’Indo-Pacifico del “QUAD”, formato da India, Stati Uniti, Australia e Giappone, per sorvegliare l’area non solo con i five eyes ma rendere concreta la presenza statale nelle acque del mare più caldo del XXI secolo. Il faro statunitense sul dragone cinese, dopo questa premessa, risulta essere tutt’altro che contemporaneo, specialmente se torniamo alle memorie del 1947 dell’architetto della guerra fredda e insigne sovietologo, come George Kennan, che sottolineò come Pechino non fosse un problema nel breve-medio periodo per Washington in quanto debole dal punto di vista industriale e impossibilitata nell’arco di pochi decenni di passare da potenza meramente continentale a dominatrice navale. In effetti, la Cina che conosciamo ed esaminiamo, nacque due anni dopo le memorie del diplomatico americano, e per oltre due decenni, per volere di Mao, fu proiettata completamente all’agricoltura, transitando, solo con la “rivoluzione culturale” della metà degli anni Sessanta, in un’epoca nuova, che vede il 1978 come avvento della Cina moderna. In quell’anno si tenne la plenaria dell’undicesimo comitato centrale del Partito comunista cinese e Deng Xiaoping, impegnato nella battaglia per rivitalizzare il comunismo cinese, intervenne in marzo alla conferenza nazionale sulla scienza. In quel discorso troviamo il progetto dirinascita della Cina, con le quattro modernizzazioni, basato sull’infrastruttura della scienza e della tecnologia. La marginalizzazione tenuta dal partito sui temi affrontati da Xiaoping aveva favorito un’arretratezza tra Pechino e il resto delle potenze globali che doveva essere colmato per ragionare, da gigante in ascesa, su vasta scala e con la velocità dei tempi richiesti, da un mondo che si era specializzato su nuovi ambiti come l’energia atomica, i semiconduttori e l’astronautica. La via pioneristica del 1978 ha introdotto il socialismo di stampo cinese, coltivato e ravvivato solamente nel 2013 con l’avvento della presidenza di Xi Jinping, caratterizzata da un’innovazione teoretica, pratica, istituzionale e culturale. Dalle quattro modernizzazioni si è passati alle quattro innovazioni, poiché Xi accosta innovazione e sicurezza nazionale, nella ricerca costante di autonomia strategica, in cui per diventare una cyber-potenza sarà necessario percorrere “la strada della sicurezza nazionale con caratteristiche cinesi”, ossia essere il più possibile autosufficienti. Il pensiero del Presidente cinese, seppur condivisibile da una prospettiva di un aspirante egemone, si scontra con il processo attuato dalla globalizzazione dei decenni passati, che ha fuso mercati e filiere, creando interdipendenze e vulnerabilità. Questo sistema, nato istituzionalmente a San Francisco con le Nazioni Unite, divenuto realtà con la fine dell’URSS, è stato messo in piedi dagli USA e si denota con le osservazioni di una storica guida della Federal Reserve come Alan Greenspan che sottolineò, agli albori della crisi del 2008, il ruolo della globalizzazione come primario rispetto alle possibili scelte di un Presidente, che al di là del partito di provenienza, negli scenari globali può essere incisivo in merito alla sicurezza nazionale, facendo trapelare l’indifferenza, sul lungo tempo, dei mercati, protagonisti dell’era capitalista. Da questa osservazione, possiamo comprendere e inquadrare le azioni degli inquilini della Casa Bianca, decisivi nelle scelte di spesa militare, alla base del capitalismo politico americano. Troviamo le fondamenta della supremazia statunitense a partire dal rapporto del 1945 di Vannevar Bush “The Endless Frontier” rivolto al presidente Roosevelt, instaurando un perpetuo finanziamento della ricerca scientifica per uso bellico che col tempo si tramuta in tecnologia civile. In questo scritto vediamo ciò che segnò il trionfo di Washington su Mosca e ciò che potrebbe insegnare l’approccio migliore nella sfida con Pechino. La guerra economico-commerciale e l’aperta lotta per la leadership tecnologica tra USA-Cina sono la forma più dirompente che assume oggi la competizione per gli equilibri del secolo. Con la caduta del muro di Berlino e dell’Unione Sovietica abbiamo assistito a un mondo unipolare caratterizzato dall’avvento della guerra asimmetrica del Golfo che coincise con il lancio World Wide Web, la base della dimensione, che a seguito della pandemia, viviamo in contemporanea con la realtà. L’affermarsi degli Stati Uniti come potenza egemone portò alla crescita costante di capitalismo, tecnologia e globalizzazione, le tre chiavi di lettura del successo americano sul comunismo sovietico. Mentre gli USA trionfavano agli occhi del mondo, la Cina avviava la svolta tecnologica e industriale, aprendo all’Occidente l’occasione di delocalizzare le industrie, portando un amento dei capitali grazie a una bassa manodopera, consentendo un’acquisizione di Know-how da parte cinese e un inizio di industrializzazione di stampo capitalistico. Con il tempo, il distacco tra la potenza orientale e occidentale si affievolì, grazie proprio alla crescita tecnologica che invocava l’uso sempre più cospicuo di terre rare. Con l’avvento dei computer, e soprattutto degli smartphone, la Cina ha preso consapevolezza di essere non solo la manifatturiera del mondo ma anche la miniera mondiale di metalli rari. Con la nascita delle case tecnologiche, che apprendevano da Apple e Samsung, Pechino ha valorizzato all’inizio del Millennio Huawei, prima tramite BT, una rete britannica, e poi con la creazione di una catena del valore interno, attraverso una cooperazione tra aziende di telecomunicazioni, come China Mobile, la costruzione di laboratori e centri di ricerca per volontà del partito, che ha favorito la crescita della Huawei in sviluppo e ricerca tra il 2014-18 del 149%. La crescita cinese resa possibile dal binomio industria-tecnologia, come preannunciato e desiderato da Xiaoping, ha allarmato Washington, che a partire dalla presidenza Obama ha cambiato postura. Nella seconda metà degli anni Dieci, in Occidente, la narrazione sulla Cina cambia, nonostante già dal 2009 il deficit commerciale degli Stati Uniti fosse nelle mani di Pechino creando un’interdipendenza molto stretta, poiché dal 2013 al 2016 Pechino ha conquistato il primato nell’ambito delle pubblicazioni scientifiche sul deep learning, risultando così la perfetta sfidante per la supremazia digitale. Infatti, sul finire del mandato, Obama ha focalizzato l’interesse governativo sulle politiche a sostegno delle tecnologie strategiche per l’economia digitale: intelligenza artificiale, big data, supercomputer, cybersecurity, 5G. Tutto ciò, ha preso valore nell’opinione pubblica con la spettacolarizzazione comunicativa di Trump, che a partire dal rapporto della National Security del 2017 ha deciso di stabilire un’invettiva permanente contro la Cina, raggiungendo l’apice in era covid-19. I due modus operandi dei presidenti americani hanno fatto si che, innanzitutto fosse la politica e la classe dirigente statunitense a prendere atto di un cambio di paradigma, con una potenza che fosse realmente competitor a distanza di decenni, e che il popolo occidentale fosse consapevole che l’ordine mondiale liberale potesse essere minato dal regime di Xi. Il sentiero di attenzioni e sensibilizzazioni instaurate a partire dal 2016, sono dovute a diversi parametri che mostrano l’incessante crescita del “dragone”. Innanzitutto, la Cina è risultata essere un problema attestandosi come prima potenza demografica e quindi anche come primo mercato di consumatori. La demografia e lo sviluppo delle tecnologie hanno inciso sull’affermazione della Cina nell’e-commerce: nel 2005, il valore delle transizioni online in Cina era inferiore all’1% del totale mondiale, che era pari a 495 miliardi di dollari; nel 2016, il valore dell’e-commerce nel mondo è salito a 1915 miliardi di dollari e la quota cinese è esplosa al 42,4%, superando gli USA, la cui quota è pari al 24,1%. Nel 2015 Xi impose un cambio improvviso dei metodi di pagamento, grazie all’hi-tech, rendendo il QR Code la chiave di pagamento contemporaneo. In sei mesi, con una popolazione di 1,3 miliardi, tutto il paese ha avuto questa trasformazione. Questa modalità di acquisto offre al governo la possibilità di conoscere transizioni e spostamenti dei cittadini. È il modello di Xi Jinping nel modificare le abitudini del popolo, affermando lo sviluppo tecnologico. Questa straordinaria crescita del commercio online è dovuta ai pagamenti attraverso gli smartphone: le transizioni mediante telefoni cellulari ammontano in Cina a 790 miliardi di dollari, un valore dieci volte superiore ai 74 miliardi $ americani. Allo stesso tempo, ciò è indice di come gli utenti virtuali siano circa 730 milioni, più di quanti ne abbiano Stati Uniti ed Europa assieme. Da questo dato possiamo notare la supremazia cinese, che è in vantaggio sul commercio principale del domani, segnando quindi un sorpasso dal punto di vista della guerra commerciale del breve e medio periodo, ma che è anche principale cittadinanza per uso di tecnologie e quindi numericamente presente sulla scena della leadership tecnologica. È da ciò che si evincono le sfide della sovranità digitale e degli imperi del secolo, tramite oligopoli digitali. Si comprende tutta l’importanza della competizione geopolitica che passa dalla sicurezza tecnologica e sicurezza strategica, mai state così unite. Una vera rivoluzione che riguarda anche il piano militare, con l’obiettivo di Pechino di superare gli Stati Uniti entro il 2049 per spesa e ricerca bellica, date le applicazioni che l’intelligenza artificiale, la supremazia del computing, l’automazione intelligente e il 5G, in particolar modo, possono avere nell’innovazione degli armamenti e delle tecniche di guerra, dagli attacchi informatici alle reti energetiche o dei trasporti del Paese. Dall’inferiorità demografica che colpisce l’Occidente, possiamo analizzare la stretta vicinanza tra USA e India, non solo per motivi geografici di tutela terrestre e degli stretti marittimi, ma soprattutto per incrementare la raccolta di dati. Come nel secolo scorso le “sette sorelle” ,coniate da Enrico Mattei, dettavano l’economia mondiale, oggi ogni territorio può diventare una miniera digitale che consente di affrontare i mercati internazionali. Ne è esempio la General Data Protection Regulation europea del 2018, presa come modello dall’India, per affermare una strategia difensiva che tuteli e valorizzi il territorio, il potenziale industriale e il mercato. Se in passato per le potenze marittime serviva mappare il territorio, oggi nel nostro secolo è fondamentale mappare gli uomini per conoscere le domande del mercato e anche in ottica di security. La Cina ha fatto della municipalità di Shenzhen (quartiere generale della Huawei) il centro della manifattura digitale, a partire dagli investimenti del 1992 quando vi fu un rilancio delle province meridionali del paese, consentendo l’avvento dell’influenza su Hong Kong e l’affacciarsi come protagonista nel Mar Cinese Meridionale. È da qui che prende forma la nuova dimensione strategica cinese. Contemporaneamente all’indipendenza di Hong Kong, nel 1997 si pongono le basi delle reti neurali e deep learning, con la nascita del computer IBM Deep Blue, noto per aver sconfitto il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. È con la fine del secolo che si percepisce come i daticostituiscano l’oro nero del nuovo millennio. Dopo la nascita di Apple nel 1976, a seguito della crisi petrolifera, sarà Google, nel 1998, subito dopo la crisi delle Tigri Asiatiche, a prendere gradualmente la scena internazionale delle tecnologie, segnando nuovamente l’avanguardia a stelle e strisce. Ma quando la Cina passa O2O, offline to online, con la crescita della Huawei, China Mobile, ZTE e in ultima istanza Xiaomi, che si lancia un piano decennale come il Made in China 2025 e Broadband China , mirando alla riduzione di indipendenza tecnologica dall’estero e di promuovere “campioni nazionali” in grado di sviluppare le parti mancanti e carenti della catena del mercato interno. Ma è sulla questione dei microchip che si infrange la volontà di indipendenza cinese, che seppur detenendo il 90% della produzione mondiale di smartphone e i due terzi della produzione di computer e smart tv, non ha un’industria dei microprocessori in grado di supportare quantitativamente questi volumi produttivi, importando nel 2017 per 270 miliardi di dollari microchip, un valore superiore all’import di petrolio (proveniente in maggior parte da Iran e Venezuela, ai quali strategicamente gli USA pongono embargo). Così dal 2014, Pechino ha creato un fondo per l’industria nazionale dei circuiti integrati, stanziando 150 miliardi di dollari, utile per superare i propri limiti e favorire un’industria di ultima generazione, necessaria per telecomunicazioni e intelligenza artificiale. L’urgenza di sottrarsi a una dipendenza americana, come la Qualcomm, che non è solo di mercato ma anche politica, ha portato alla raccolta fondi per Xiaomi per consentire di disegnare e produrre un microprocessore specificamente per smartphone, portando Huawei a concentrarsi sulla creazione di un sistema operativo per poter rompere ed evitare un’offensiva geopolitica da parte di Google, controllore totale della supply chain. Se gli USA con Trump hanno agito con sanzioni ed embarghi per contrastare la tecnologia e crescita di potenza cinese, Pechino ha a disposizione un’arma di ritorsione: le terre rare. Il problema, dal punto di vista americano, nasce dal fatto che più del 70% della produzione di terre è concentrata sul suolo cinese, tanto che l’industria statunitense ne dipende per ben l’80% delle sue necessità. 15 elementi rari che oggi sono fondamentali per lo sviluppo delle tecnologie costringono Washington a delle mosse strategiche ben precise, dal momento in cui la capitale dei lantanoidi si trova nella Mongolia Interna, nell’area mineraria di Bayan Obo. Oltre alla principale riserva, la Cina ha 10.000 miniere di terre rare attive. Dal 2013, con l’era Xi, vi è stato un freno per le estrazioni minerarie da parte di industrie straniere, portando una nazionalizzazione delle imprese, a differenza della nazionalizzazione delle risorse scelta da Morales in Bolivia per il litio, pagata caramente con la tensione con gli USA. Dopo l’embargo nei confronti della Cina a seguito di piazza Tienanmen, il dragone puntò a essere autosufficiente dal punto di vista minerario, innescando la consapevolezza del leader Xiaoping che disse nel 1992:”Il Medio Oriente ha il petrolio. La Cina ha le terre rare”. In effetti, i 14 paesi OPEC totalizzavano il 41% della produzione mondiale di oronero, Pechino si arroga fino al 99% della produzione di terre rare secondo stime contemporanee che possono raggiungere il totale nell’arco di quindici anni. Preso atto della supremazia mineraria cinese, gli Stati Uniti per superare questo ennesimo “Sputnik moment”, hanno iniziato a porre un freno alla delocalizzazione, che ha portato dagli anni Ottanta un raddoppio del PIL di Beijing, e rivitalizzando la Committee on Foreign Investment, sviluppando il binomio pubblico-privato per una ricerca avanzata su come colmare questa carenza materiale. È grazie alla talassocrazia che ha consentito a Washington di dominare il XX secolo che oggi si può sviluppare, grazie al controllo dei cavi sottomarini e con la U.S. Navy, il nuovo capitolo di Blue Economy, essendo il 71% del pianeta costituito da mare, e con lo scioglimento dei ghiacciai e con la strumentazione tecnologica satellitare che consente di mappare i giacimenti di terre rare, si può andare alla ricerca di nuove miniere oceaniche. In questo ambito, Washington pone l’attenzione verso la Groenlandia e l’Artico per: usufruire del soft power della ricerca scientifica, delle risorse di petrolio, carbone e mettere un blocco alla Silk Road. L’azione governativa è coadiuvata da Facebook, che con il progetto del cavo sottomarino Simba, annunciato sul WSJ, vorrebbe abbattere i costi di connessione tra paesi costieri e internet globale, e Google che ha aperto in Ghana un centro d’intelligenza artificiale, sottraendo il dominio Huawei in Africa, dove ha costruito il 70% delle reti 4G. È con la tecnologia che gli USA vorrebbero erodere il controllo dell’Africa gialla, terra che va dalla zona dei Grandi Laghi a Gibuti, tra coltan, cobalto e controllo delle infrastrutture terrestri e marittime, utili ai fini degli snodi commerciali. Ma è con la ricerca spaziale che gli Stati Uniti possono vincere il conflitto con la Cina, dal momento in cui la NASA è affiancata da privati del calibro di Elon Musk e Jeff Bezos, con SpaceX e Amazon. Si deve al primo la spinta dell’innovazione spaziale, rivolta verso Marte e gli asteroidi, quest’ultimi preziosi avendo valori vertiginosi di elementi rispetto alla crosta terrestre ( 17x idrogeno, 75x carbone, 74x azoto, 4x ferro, 27x cobalto, 155x nichel, 810x rutenio, 180x rodio, 44x palladio, 440x osmio, 540x iridio, 196x platino), utili per l’industria spaziale, automotive e hi-tech. Con Bezos invece si ha un’attenzione rivolta alla Luna, grazie anche al progetto Artemis, per sviluppare sul satellite l’hub del commercio avanguardista, staccando la potenza orientale sulla logistica. La Luna è anche interessante per l’abbondanza di minerali come neodimio, disprosio, europio, terbio e ittrio, utili per creare leghe e magneti, laser, schermi per computer e tecnologia medica. È con il dominio navale e spaziale che Washington può dettare per decenni ancora la linea, a seguito dei fallimentari tentativi del Chinese Space Program, e con la leadership della comunità internazionale. Nonostante la crescita formidabile, la Cina ha incontrato, a partire dal 2010, il primo embargo della transizione ecologica e digitale che si è trasformato nell’arco di 6 anni come terreno di prova con gli USA ed è diventato un limite allo “sviluppo consentito” per oltre 40 anni senza ingerenze sostanziali. Pechino può contare sulla propria demografia che regge l’economia di mercato e le grandi industrie Hi-tech, oltre all’affermazione come principale realtà per numeri di miliardari che però, come dimostrato nel caso di Jack Ma, non risultano cooperare completamente nella dicotomia statunitense Stato-impresa. È da ciò, invece, che si ricava la forza trainante nel conflitto “bipolare” per Washington, che grazie all’élite imprenditoriali riesce a gestire e favorire una presenza multisettoriale e uno sviluppo delle innovazioni,consentendo di difendere il ruolo geopolitico. Probabilmente, la contesa egemonica, oltre a svilupparsi tra Africa, oceani, intelligenza artificiale e spazio, potrà giocarsi sicuramente nel breve-medio termine nel Pacifico, tra il Mar Cinese Meridionale con le isole artificiali di Pechino e l’influenza americana che parte dall’ex colonia delle Filippine e si prolunga verso Hong Kong, con la questione dei diritti civili, e Taiwan, la fonderia mondiale di microchip. È dall’isola del Pacifico che dovrà decidersi l’avvento dell’era cinese o la coesistenza con l’impero americano.